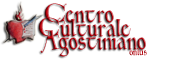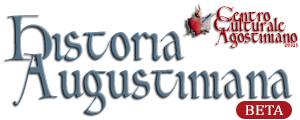Il primo ottobre 1250 papa Innocenzo IV concede quaranta giorni di indulgenza a chi avesse contribuito con elemosine alla fabbrica della chiesa e del convento che gli eremitani Brettinesi della diocesi di Fano volevano costruire in Gubbio. L'11 giugno dell'anno seguente i frati di Brettino ricevono in donazione dall'eugubino Iacomellus Clerici Marie Fregie una casa ed altri beni immobili per l'edificazione del loro convento. La comunità era allora composta da sette frati e dal priore o "guardiano", fra Bonaparte. Poco dopo, esattamente il 12 febbraio del 1253, il Comune di Gubbio dona agli agostiniani una vigna posta alle falde del monte Goregge (ora d'Ansciano) per edificare il loro convento. Un'altra vigna contigua, confinante tra l'altro con il torrente Cavarello, viene venduta da Ricca di Andrea nel 1254 al priore fra Rinaldo, sempre per la costruzione del detto luogo. Nel 1258 papa Alessandro IV autorizza i frati di Sant'Agostino di Gubbio a "pegliare d'usure e de rapine" la somma di 360 libbre di denaro lucchese. Altre donazioni, compere e concessioni in enfiteusi di terreno circostante a quello già posseduto dagli eremitani sono documentate nei decenni seguenti (per essere precisi nel 1263, nel 1266-1267, nel 1269, nel 1271 - quando viene espressamente citata la chiesa di Sant'Agostino -, nel 1278, nel 1286), a testimonianza delle dimensioni sempre maggiori assunte dall'insediamento eugubino. Da una bolla di papa Niccolò IV del 1292, citata da Piero Luigi Menichetti (1987), si apprende che la chiesa e il convento degli eremitani erano allora già terminati. Nel 1293 Druda di Giacomo viene accolta come oblata nel convento eugubino. A tutela della chiesa di Sant'Agostino durante i lavori di ampliamento della cinta muraria di Gubbio, scende addirittura in campo, nel 1302, il cardinale Napoleone Orsini, che si rivolge al vescovo di Gubbio affinché non sia fatto "pregiudizio alla detta Chiesa dei frati Agostiniani". Nel 1335 ben due comunità locali di suore abbracciano la regola di Sant'Agostino e si sottomettono al convento eugubino. Si tratta dei monasteri di Sant'Orsola e di Santa Cecilia, rispettivamente guidati da suor Agatella e suor Luminella. Un riconoscimento dell'importanza assunta, nell'ambito della comunità eugubina, dal convento degli eremitani già nel secolo XIV, si può ravvisare in una delibera presa dal consiglio generale del popolo, dai capitani delle arti, dai consoli e dai mercanti della città nel 1339: il giorno della vigilia della festa di Santa Caterina tutti gli artefici, con "cereis faculis e candelis adcensis in manibus", avrebbero dovuto recarsi dalla piazza del mercato alla chiesa di Sant'Agostino "procexionaliter et ordinate". Nel 1341 "Masscius Hostii" dispone un legato testamentario a favore degli agostiniani per la costruzione nella loro chiesa di una cappella "ad honorem Dei et sue matris Virginis Marie et beatorum Augustini, Iohannis et Nicole de Tolentino". Tre anni dopo questa data i frati eremitani raggiungono il numero di 29, compreso il priore fra Bonaventura da Gualdo, per diminuire poi vistosamente dopo la peste nera (15 frati nel 1362, 18 nel 1365 e nel 1369, 20 nel 1370). A partire dalla metà del Trecento sono documentati lasciti testamentari per l'acconcime della chiesa: nel 1358 Francesco di Paolo destina a tal fine 25 libbre, e lascia inoltre una tovaglia "pro altare ecclesie"; nel 1363 Pietro Francesco di Corraduccio, conte di Petroia, dona tutto il suo patrimonio al Convento di Sant'Agostino (anche se particolari clausule testamentarie impediranno di concretizzare la volontà del nobile eugubino); nel 1383 Balda del fu Giacomo della Serra lascia 100 fiorini d'oro per la pittura del coro e la sua risistemazione. Pressappoco allo stesso periodo risalgono pure gli inventari della sacrestia di Sant'Agostino, trascritti prima dal Mazzatinti (che legge erroneamente diverse date) e poi dal Lopez: quelli noti sono infatti del 1341, 1345-1346, 1358, 1366, 1368, 1374, 1382. L'inventario del 1366 ci permette di risalire ai titoli di quattro altari della chiesa, rispettivamente dedicati a San Giovanni, al Crocifisso, a Santa Maria e a Santa Caterina. Quello del 1374 ci informa che nel convento esistevano allora due dormitori, il vecchio con cinque celle ex parte orientis ed altrettante ex parte ocidentis, e il nuovo con undici celle. Alla fine del Trecento datano invece le prime notizie su esenzioni e tasse a cui era soggetto il convento: il 6 gennaio 1393 il Comune esenta gli agostiniani dal pagamento delle gabelle del vino, della biada etc.; quattro anni più tardi gli eremitani sono messi a ruolo per 15 libbre nel nuovo allibrato per le tasse dei luoghi pii. Legati in favore della chiesa e del convento, in particolare finalizzati alla costruzione di cappelle, si susseguono per tutto il Quattrocento. Già nel 1393-1394 Marino Massarelli aveva lasciato ai frati una vigna per finanziare la costruzione di una cappella nella loro chiesa (anche se poi gli agostiniani gli avevano assegnato la cappella già esistente di Santa Caterina, ubicata vicino la porta del cimitero). Nel 1434 Romano di Berto Benveduti destina 50 fiorini d'oro alla costruzione di una cappella sotto il pergolo, a sinistra entrando in chiesa, secondo le decisioni di suo fratello Gabriele, vescovo di Sagona in Corsica. A quanto sembra la stessa cappella, dedicata alla Madonna, viene nel 1478 donata dalla vedova di Bartolomeo di Gaspare ai frati, che assumono l'onere del suo mantenimento in cambio dei beni ereditari del detto Bartolomeo. Nel 1445 la vedova di Pietro Balducci nomina erede universale la chiesa di Sant'Agostino, precisando che i beni da lei lasciati dovranno essere convertiti "in fabrica et ornamento dicte ecclesie in calicibus et paramentis". Nel 1447 i frati donano, invece, a Pietro di Domenico e ad altri suoi congiunti una sepoltura sul lato sinistro del coro. Attorno al 1439, in seguito a un arbitrato, alla chiesa agostiniana viene unita quella di Santa Maria Nuova, rivendicata dai monaci di Santa Maria d'Alfiolo. All'inizio del Cinquecento, precisamente nel 1508, la Confraternita del Crocifisso di Sant'Agostino dichiara di essere unita ed annessa al convento di Sant'Agostino. Nel 1518 gli agostiniani, per sfruttare l'esigua fascia di terreno che possedevano tra la chiesa e la strada pubblica (attuale via di Porta Romana), decidono di cederla in enfiteusi a diversi privati, concedendo loro la facoltà di erigervi botteghe e magazzini. Ha dunque luogo la costruzione di piccoli edifici, ancor oggi esistenti, a ridosso della parete sudoccidentale della chiesa. Tra le botteghe edificate vi sono quelle del figulo Pierrosato di Filippo e del fabbro Polonio di Cherubino. Ai decenni iniziali del Cinquecento risalgono pure le prime notizie reperite su un'immagine della Madonna della Misericordia posta nel chiostro del convento, ed ora non più esistente. Nel 1540 la vedova di Bartolomeo Pelingotti da Cagli, nel suo testamento, dispone la costruzione di una cappella in chiesa. Il Cinquecento sembra essere stato un periodo particolarmente florido per la comunità agostiniana eugubina. Lo testimonia, tra l'altro, un singolare esposto del medico fisico "messer Ottaviano" indirizzato alla magistratura cittadina. Il medico asserisce di essere stanco di litigare con il priore di Sant'Agostino per il compenso a lui dovuto in seguito alle "fattighe, e cure fatte alli infermi" del convento. Afferma di non essere tenuto a visitare gli agostiniani, contrariamente a quanto ritiene il priore citando un passaggio dei capitoli della condotta. Infatti il fisico ha l'obbligo di visitare i malati "in monasterijs pauperum, dove si deve molto ben considerare che dice pauperum, et non dice mendicantium: perché il convento di S.to Agostino si bene per regula si chiama mendicante, niente di manco per la verità è ricco: che perciò tiene lo studio, et continuamente dà denari a censo, e tanto più che ha più di due mila scudi di entrata l'anno: perché Pauperes sunt, qui nihil possidunt: ma li Padri di S.to Agostino possedono tanto che empiano una grossa cantina di vino, fanno un buon granaro, et empiano una buona borsa di denari". Messer Ottaviano supplica pertanto la magistratura di confermagli il capitolato sull'esenzione dalle visite a Sant'Agostino. Grandi lavori di trasformazione interessano la chiesa a partire dai tardi anni Sessanta del XVI secolo. Internamente Sant'Agostino viene provvista di archi lungo le pareti laterali, atti ad ospitare otto cappelle per lato. Probabilmente è in questa occasione che la facciata della chiesa viene ricostruita, al pari della prima campata della chiesa e del relativo arco diaframma. I rimanenti arconi trasversali sono ispessiti per poter poggiare sui nuovi pilastri, costruiti internamente a rinforzo di quelli esterni a sezione semicircolare. Diversi documenti archivistici testimoniano la concessione a privati e la conseguente erezione delle cappelle laterali della chiesa, soprattutto negli anni Settanta del Cinquecento. Famiglie come gli Andreoni, i Damiani, i Mattioli, i Paolozzi, gli Sforzolini, i Traversi costruiscono allora i loro sacelli in Sant'Agostino. Altri nobili eugubini, ad esempio i Febini, lasciano nei loro testamenti somme cospicue di denaro per erigere nuovi altari nella chiesa. Notizie puntuali si hanno nel caso della cappella Damiani, realizzata verso il 1575 da maestro Lorenzo muratore: in tale circostanza vengono stimate le opere relative ai cornicioni, ai muri, ai risalti, agli intonaci, all'altare e alla volta del sacello. Il rinnovamento decorativo dell'interno della chiesa comporta pure altre opere in aggiunta di quelle delle relative cappelle. Viene ad esempio ammodernato l'organo, e probabilmente sono rifatti anche altri arredi chiesastici. In Sant'Agostino lavorano allora i principali artisti eugubini del tempo. Per fare solo l'esempio dei pittori, lasciano opere nella chiesa degli eremitani: Benedetto e Virgilio Nucci, Giovanni Maria Baldassini, Pier Angelo Basili, Felice Damiani. La prima lista degli altari della chiesa di Sant'Agostino reperita tra le carte d'archivio risale al 1588, anno della visita pastorale del vescovo Mariano Savelli. Ecco i titoli dei sacelli ricordati in questo documento: San Lorenzo, dello Spirito Santo, l'Assunta, la Madonna del Soccorso, San Sebastiano, la Madonna sulla Neve, "San Maritano", "la cappella di m. Joseffe Sforzolini", San Michele Arcangelo, San Nicolò, San Rocco, Santa Caterina, Santa Maria Maddalena, San Valentino, Sant'Antonio, il Crocifisso. Altre notizie sugli altari si ricavano da successive visite apostoliche, come quella del vescovo Sorbolonghi del 1606, che dovrebbe menzionare solo le cappelle che attendono ancora un'adeguata sistemazione. Gli altari in oggetto, designati perlopiù col nome del relativo proprietario, sono quelli "del Pellini sotto l’organo”, di Giovanni Paolo Sensi, di Ubaldo Raffaelli, dei Nucci, di Lorenzo Traversi, di Girolamo Bruni, dei Troppoli, di Giuseppe Bovarelli, degli Zanzi, di Pietro Abbati, di San Nicola e dei Franciarini. Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento si susseguono le disposizioni ed i lasciti testamentari di privati eugubini per l’acconcime della chiesa e l’ornamento delle cappelle. Tali lavori comportano uno sforzo economico assai elevato, tanto che nel 1608, con l’interessamento del Comune di Gubbio, si rendono necessarie pressioni nei confronti dei superiori degli agostiniani per poter compiere la fabbrica già iniziata. Ricordiamo qui, per inciso, che all’inizio del Seicento trascorre nel convento di Gubbio gli ultimi anni della sua vita l’eugubino fra Evangelista Quattrami, celebre semplicista agostiniano, per molti anni al servizio della casa d’Este. Nel corso del XVII secolo la chiesa assume un nuovo aspetto, grazie soprattutto all’erezione di tre grandi mostre d’altare: quella lignea dell’altare maggiore, spettante alla compagnia del Santissimo Sacramento, realizzata tra il 1640 e il 1645 da Giacomo Casali su disegno del pisano Michele Buti; quella in stucchi dell’altare della Madonna del Soccorso, spettante alla compagnia della Madonna della Cintura, realizzata tra il 1636 e il 1638 dai fermani Simone di Adriano e Antonio di Pietro Marini; quella lignea dell’altare di San Nicola da Tolentino, posta dirimpetto alla precedente, e realizzata a quanto pare negli anni Cinquanta del Seicento. Accanto a questi lavori di ammodernamento dell’interno della chiesa, assistiamo pure alla erezione di altri altari come quello della Gratiæ Mater (1648), anch’esso spettante ad una compagnia, o quello di San Tommaso da Villanova (notizie dal 1666), nel quale vengono collocate le reliquie del Beato Pietro. Al Settecento, molto probabilmente al 1731, risale il primo minuzioso inventario della chiesa e della sacrestia, il quale ci fornisce l’elenco esatto delle cappelle, dei manufatti e degli arredi sacri allora conservati in Sant’Agostino. Sono questi all’incirca gli anni in cui il priore Agostino Moio, secondo la testimonianza di padre Pietrangelo Damiani (1756), “ingrandì di abitazioni” il convento, “e la hiesa adornò di sacri Arredi, di Coro e di Altari”. Un altro interessante documento è quello del 1784 dal quale si apprende che i frati, avendo intenzione di spostare l’organo sulla controfacciata della chiesa e di erigere all’uopo una nuova cantoria, decidono di liberare le prime due cappelle, poste una a destra e l’altra a sinistra entrando e quindi di eliminare i relativi altari della Samaritana e di Sant’Antonio Abate. Sono probabilmente questi gli anni in cui le pareti della chiesa vengono per la prima volta ricoperte di bianco e in cui è realizzata la bussola nell’ingresso principale. Il 25 gennaio 1798, durante la Repubblica Cisalpina, il convento di Sant’Agostino viene soppresso: poco dopo (29 marzo) si pensa addirittura di trasferire nei locali dell’ex convento il lanificio già nel Rifugio Pio, con tutte le relative attrezzature. Ma poco dopo l’insediamento agostiniano ritorna ai legittimi proprietari, che ne rientrano formalmente in possesso il 23 gennaio dell’anno 1800. Il 20 agosto 1854 la chiesa viene solennemente consacrata dal Cardinale Giuseppe Pecci, Vescovo di Gubbio. Con l’unità d’Italia il convento è nuovamente soppresso e i frati nel 1869 sono espulsi e costretti a rifugiarsi in una piccola casa di Gubbio, eretta a sede temporanea della loro parrocchia. Nel 1882, dopo aver ampliato la loro provvisoria residenza tramite l’acquisto di una casa contigua, gli agostiniani possono fare di nuovo “vita perfetta comune” e si assoggettano alle disposizioni all’uopo emanate dalla casa generalizia di Roma. Il convento demaniato passa nel frattempo in proprietà alla famiglia genovese Degola; nel 1897 Giacomo Sciallero Carbone, sempre di Genova, se lo aggiudica a un’asta pubblica. In seguito viene acquistato dai fratelli Costa, della stessa città. I frati ritornano in possesso del loro luogo, sebbene solo parzialmente, nel 1901: l’acquisto era stato perfezionato dal priore Giacomo Belgrano e da suo fratello Pietro, vicario generale. Per la compera ed il restauro del complesso sono spese £ 20.000. In questa occasione viene riscoperto, tra l’altro, il grande affre-sco quattrocentesco dell’arco trionfale, raffigurante il Giudizio Universale. Il convento torna subito a rifiorire, tanto che quattro anni dopo (1905) è inaugurato il noviziato di Sant’Agostino, e padre Giacomo Belgrano è nominato maestro dei novizi. Attorno al 1920, a cura della Soprintendenza, si opera il trasferimento nella chiesa di Santa Maria Nuova dell’ornamento ligneo dell’altare maggiore, per rendere visibili gli affreschi del Nelli posti sulle pareti del coro. Con Regio Decreto del 1° ottobre 1931 viene riconosciuta personalità giuridica alla “Provincia dell’Umbria con sede in Gubbio, dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani”. Dopo l’incendio che nel 1957 distrugge l’altare di San Tommaso da Villanova e l’urna del Beato Pietro, gli eremitani si fanno promotori, con il contributo sostanziale della Soprintendenza dell’Umbria, dei restauri di alcuni dipinti murali della chiesa, tra i quali spiccano gli affreschi del coro e dell’arco trionfale (1965 circa). Dieci anni dopo anche due pale d’altare, da tempo giacenti nel Museo Comunale di Gubbio, sono riportate a Sant’Agostino, anche se una, quasi sicuramente, non era in origine in questa chiesa.
Scheda di approfondimento
Insediamento
Complesso conventuale
Edificio di culto
Dipendenza