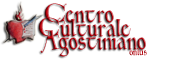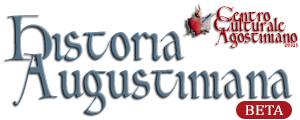Quello di Ascoli è uno dei più antichi insediamenti agostiniani delle Marche. La presenza dei frati agostiniani è attestata nell’Ascolano già nel 1238, quando il vescovo di Ascoli Matteo concesse ai frati un sito sul colle Morice per costruirvi un nuovo convento, poiché il loro insediamento di Cignano nei pressi della città, le cui origini erano legate alla Congregazione di Brettino, versava in rovina. Ulteriori documenti sono datati 1247-1248: una bolla di papa Innocenzo IV (1248) concedeva quaranta giorni di indulgenza a chi avesse contribuito alla costruzione di chiesa e convento. Un documento probabilmente del 1262, citato dal Pastori, attesta la conferma da parte del vescovo di Ascoli Rinaldo III della proprietà del sito, seguita da una bolla di papa Urbano IV dello stesso anno da cui risulta la presenza degli Agostiniani in città. Il convento non fu infine realizzato sul colle Morice, ma nella piana tra i fiumi Tronto e Castellano, nel centro di Ascoli; l’edificio originario fu iniziato prima del 1242, interrotto per l’occupazione sveva di Ascoli e ripreso nel 1248; nuovamente interrotto nel 1255 e nel 1260 da papa Alessandro IV, fautore dei Minori che avversavano gli Agostiniani, fu ancora ripreso nel 1262. La chiesa fu ricostruita nel 1317 e conclusa nel 1381, di dimensioni notevolmente maggiori della precedente. Fu mantenuta la parete nord di cui permane qualche resto. Il primitivo edificio era a navata unica con copertura a capriate lignee. L’attuale chiesa è invece frutto della ricostruzione tre-quattrocentesca con varie appendici costruttive protrattesi fin oltre la metà del XVI secolo.
L’edificio ecclesiastico, costruito in conci di travertino squadrati e spianati, presenta caratteristiche morfologiche piuttosto inusuali nel quadro delle realizzazioni architettoniche riferite agli Agostiniani. Nella sua attuale configurazione la chiesa, a tre navate voltate a crociera annunciate già dalla tripartizione affidata a due lesene in facciata, è riferibile alle trasformazioni quattrocentesche. La facciata stessa, a coronamento orizzontale, costituisce un caso interessante in ambito agostiniano: un altro esempio legato allo stesso Ordine si trova nella successiva Sant’Agostino di Ripatransone (XVII-XVIII secolo). Tale tipologia, diffusissima nelle chiese abruzzesi conta comunque, nelle Marche, altri esempi non agostiniani nella stessa Ascoli e a Visso. Leperture in facciata sono tre oculi, uno grande corrispondente alla navata principale e due piccoli corrispondenti alle laterali. L’unico portale centrale, timpanato a tutto sesto, decorato con festoni fitomorfi e testine antropomorfe e zoomorfe, e definito ai lati da due paraste rudentate a 1/3 sormontate da capitelli di fantasia, è ascrivibile a una più tarda fase, cinquecentesca. L’abside presenta un profilo poligonale, mentre la decorazione architettonica è affidata a lesene e archetti nelle fiancate. La torre campanaria ha aperture bifore. L’interno della chiesa, non eccessivamente decorato, presenta pilastri compositi a base quadrangolare con quattro semicolonne addossate in croce su cui impostano archi a tutto sesto sulla navata centrale e archi acuti sulle laterali a sostegno delle crociere, sormontati da capitelli pseudo-corinzi di fantasia, decorati con ovuli, rosette, volute e varie decorazioni fitomorfe.
La prima fase di ricostruzione della chiesa si protrasse dal 1317 al 1414. Alla fine del Quattrocento l’impianto fu modificato e portato a tre navate coperte da volte. L’attuale facciata fu completata nel 1546, e l’anno seguente vi fu aggiunto il portale, opera del lombardo Lazzaro di Francesco detto Ferrone, conclusa da Pietro di Domenico detto Comisio. È possibile definire con sufficiente esattezza le vicende architettoniche dell’interno della chiesa: tra il 1483 e il 1485 vi lavorarono i lapicidi toscani Giuliano Zanobi e Apollonio Martini di Pietro da San Miniato che vi eseguirono i pilastri polistili, le ghiere ovulate, gli archi delle navate e i capitelli; la presenza dei lapicidi toscani è attestata sino alla fine del 1485. I lavori furono conclusi nel 1520 da parte di maestranze padane (il veneto Pietro di Stefano e Berardino di Pietro da Carona, e, soprattutto, i lombardi Giovanni di Guglielmo detto Bozo e Franco di Stefano che eseguirono le volte a crociera, e Giovanni detto Maiolo di Ganza-Varese e Matteo da Sala che nel 1519 completarono le navate). I lavori dell’interno furono definitivamente compiuti nel dicembre del 1520. L’abside poligonale è stata invece eseguita ex novo nel 1514 dal piacentino Alberto di Rasino di Fontana, mentre la facciata in travertino era già compiuta nel 1546 quando vi fu eseguito il portale dagli artisti lombardi. Nel XVII-XVIII secolo furono aggiunti gli altari laterali all’interno: due di questi sono opera degli ascolani Giuseppe e Lazzaro Giosafatti, che li eseguirono nel 1720 e nel 1731. Nel 1936 Luigi Serra, nel descrivere l’edificio, parlò di «interno rifatto con arco trionfale originario rimurato, affresco del sec. XV, altare barocco. Proprietà del Comune». L’attiguo convento, che si sviluppa attorno a un chiostro cinquecentesco definito sui quattro lati da un possente colonnato con capitelli pseudo-dorici, presenta all’esterno forme riconducibili a radicali interventi presumibilmente ottocenteschi. Nel 1996 è stato approvato un progetto per la risistemazione del complesso conventuale, destinato a diverse funzioni.
Nella navata sinistra si trova un affresco di Cola dell’Amatrice raffigurante Cristo che porta la Croce sull’altare maggiore, una tavola con la Madonna con Bambino di Francesco Ghissi, allievo di Allegretto Nuzi (1359-1395); nel coro erano poste due colonne romaniche in travertino a forma di figure umane (Adamo ed Eva), trasferite oggi nel palazzo vescovile. L’opera d’arte di maggior interesse custodita nella chiesa è il celeberrimo quadro raffigurante la Morte di san Francesco Saverio di Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639-1709), dipinto nel 1682. Un’ultima tela, raffigurante Sant'Eustachio ed eseguita dal Trevisani su committenza dei soldati corsi, è collocata nell'altare di Lazzaro Giosafatti.
Paolo Cruciani